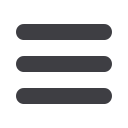35
innovazione.PA
|
01-02/2018
| ANNO XV GENNAIO - FEBBRAIO
“B
isogna avere fortuna, è un po’ come la
maestra alle scuole elementari, se ti capita
quella brava bene, altrimenti...”
queste
le parole di un dirigente della Pubblica
Amministrazione che ha frequentato
i corsi di aggiornamento della Scuola
Superiore dell’Amministrazione,
denominata dal primo gennaio 2013, Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA). Certo, immaginare che la
preparazione di un amministratore della cosa pubblica possa
dipendere dalla buona sorte, può suscitare perplessità grandi
almeno quanto l’ipotesi che sia sempre l’aletorietà del caso a
governare l’apprendimento elementare di un bambino. Ma, come
è organizzato veramente il sistema di formazione dei funzionari
e dirigenti della Pubblica Amministrazione in Italia? L’esigenza
di un sistema di formazione si delinea già nei primi anni di vita
della Repubblica e si sostanzia con l’istituzione della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione nel 1957. Si aprono
diverse sedi non solo a Roma e a Bologna, ma anche e soprattutto
al Sud, è qui che maggiormente c’è interesse verso il “posto
pubblico”. Così vengono aperte sedi a Acireale, Reggio Calabria
e Caserta, dove si sceglie un luogo prestigioso, la Reggia di Carlo
III di Borbone. Nessuno avrebbe potuto immaginare allora,
scrive il giornalista Sergio Rizzo nel suo libro “la Repubblica
dei Brocchi: il declino della classe dirigente italiana”, l’incuria
nella quale sarebbe naufragato quel luogo negli anni successivi.
Forse il processo formativo della classe dirigente italiana ha
coinciso con quello della sua sede più prestigiosa? Il decreto
legge n.95 del luglio 2012, sancisce la nascita del Sistema Unico
di Reclutamento e Formazione. Infatti nei decenni precedenti,
nacquero molteplici scuole di formazione del pubblico impiego:
la Scuola Superiore di Economia e Finanza (SSEF), la scuola
del Ministero degli Esteri, del Ministero dell’Interno (SSIA),
il Centro di Formazione della Difesa, la Scuola di statistica e
di analisi sociali ed economiche, l’Istituto Diplomatico e non
solo. Viene istituito un Comitato di Coordinamento delle scuole
in modo che si possano pianificare efficientemente le attività.
Questo è il primo passo verso la soppressione delle singole scuole
e la loro unificazione sotto la Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione che avviene con l’articolo 21 della legge n.114
del 2014. Lo stesso articolo prevede che i docenti ordinari
e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della SSEF vengano
trasferiti alla SNA e il loro stipendio venga equiparato a quello
dei professori e dei ricercatori universitari di pari anzianità. Si
occuperà di questo il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 novembre 2015, n.202. Qui cominciano i primi
problemi per la riforma della SNA. I redditi degli ex docenti
SSEF, infatti sono compresi tra 116 mila euro e 301 mila euro
l’anno, ben al di sopra della media delle somme attese dal
governo e quindi partono i primi ricorsi al TAR del Lazio dei
professori che vedono il loro stipendio decurtato. Il bilancio 2018
della SNA conserva “prudentemente” una posta di un milione
e seicentomila euro per “spese per docenti ex SSEF”, infatti i
professori hanno vinto per ora e si attende il parere del Consiglio
di Stato. Il persorso di riforma del sistema di formazione ha
incontrato un altro ostacolo, almeno per il momento, un
vero e proprio semaforo rosso. Si tratta della dichiarazione di
incostituzionalità di alcuni punti della nota “Legge Madia”
(legge n.124/2015) relativa ai decreti attuativi su dirigenza
pubblica e servizi pubblici locali. L’art.11 tratta la revisione
dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione con “eventuale
trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento
di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto
prestigio, in coerenza con la disciplina dell’inquadramento e
del reclutamento, in modo da assicurare l’omogeneità della
qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli”.
Per portare a termine questa missione il governo Renzi, nel
marzo del 2016, nomina un commissario, il
prof.
Bruno Dente
già incaricato nel 1998 dal ministro della Funzione Pubblica,
Franco Bassanini, di studiare i meccanismi di perfomance della
pubblica amministrazione. “Il mio compito da Commissario”,
dice il professore di Analisi delle Politiche Pubbliche presso il
Politecnico di Milano (oggi in pensione), era quello di attuare
la riforma della scuola contenuta nella legge Madia, ossia la sua
trasformazione in agenzia e la sua uscita dalla struttura della
Presidenza del Consiglio. Questo era il dettato di un articolo
del decreto legislativo sulla riforma della dirigenza prima
approvato dal Consiglio dei Ministri, ma mai pubblicato in
Gazzetta Ufficiale perché la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’incotituzionalità della legge delega. La riforma della dirigenza
quindi non c’è mai stata. La sentenza della Corte è stata un
po’ curiosa. Infatti, che il decreto legislativo sulla dirigenza,
in particolare per la parte relativa al ruolo dei dipendenti delle
Regioni, fosse a rischio di incostituzionalità, allora lo sapevamo
tutti, credo. Anche i giuristi pentiti, come me. La Corte ha
dichiarato che non si poteva fare il decreto legislativo senza
l’intesa con le Regioni, ma questo con la SNA non c’ entrava
niente. Eppure con la legge delega sono state bloccate anche la
riforma della scuola e il piano di riorganizzazione di cui mi sarei
dovuto occupare. La mia nomina non si giustificava più, così
a Febbraio del 2017 è stato nominato il nuovo presidente della
SNA, il professor Stefano Battini.”
Le motivazioni legate all’accorpamento delle scuole racchiudono
anche un elemento di contenimento dei costi. Si procede
infatti anche alla chiusura delle sedi periferiche della SNA,
fatta eccezione per quella di Caserta. Prosegue il prof. Dente:
“la mia nomina a Commissario prevedeva anche il risparmio
che era stato inserito nella Legge Finanziaria. Ho ridotto il
numero dei docenti stabili, anzi per la verità non ne ho rinnovato
quesi nessuno. Il sistema di formazione costava enormemente,
secondo i miei calcoli, un’ora di lezione costava intorno ai 2000
euro. Da questo punto di vista il problema che aveva la scuola
non era certo la mancanza di soldi e in effetti non riusciva
neanche a impegnarli tutti, ma dove e come li spendeva.” Dal
bilancio previsionale del 2018 effettivamente risulta che le
entrate della SNA ammontano a circa 14 milioni di euro cui
vanno aggiunti circa 12 milioni di euro di avanzo di esercizio
dell’anno 2017. Alla “formazione e reclutamento”, ossia al suo
core business, sono destinati circa 15 milioni di euro, di cui il
40% circa, è destinato agli stipendi dei docenti. Le spese che la
scuola sostiene per il personale però, sono ben più alte. A queste
somme è infatti necessario aggiungere il costo del personale non
docente che fa parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.