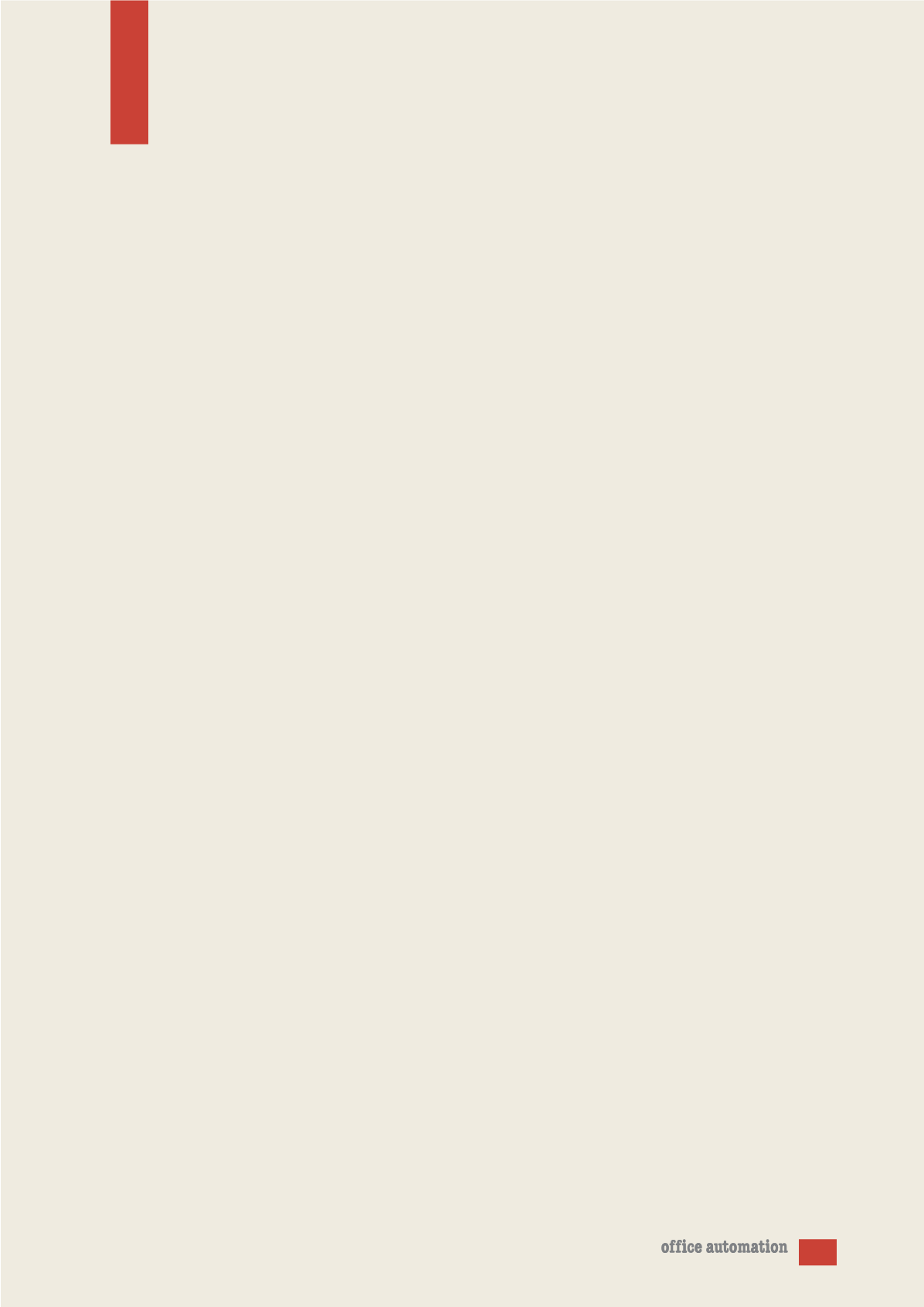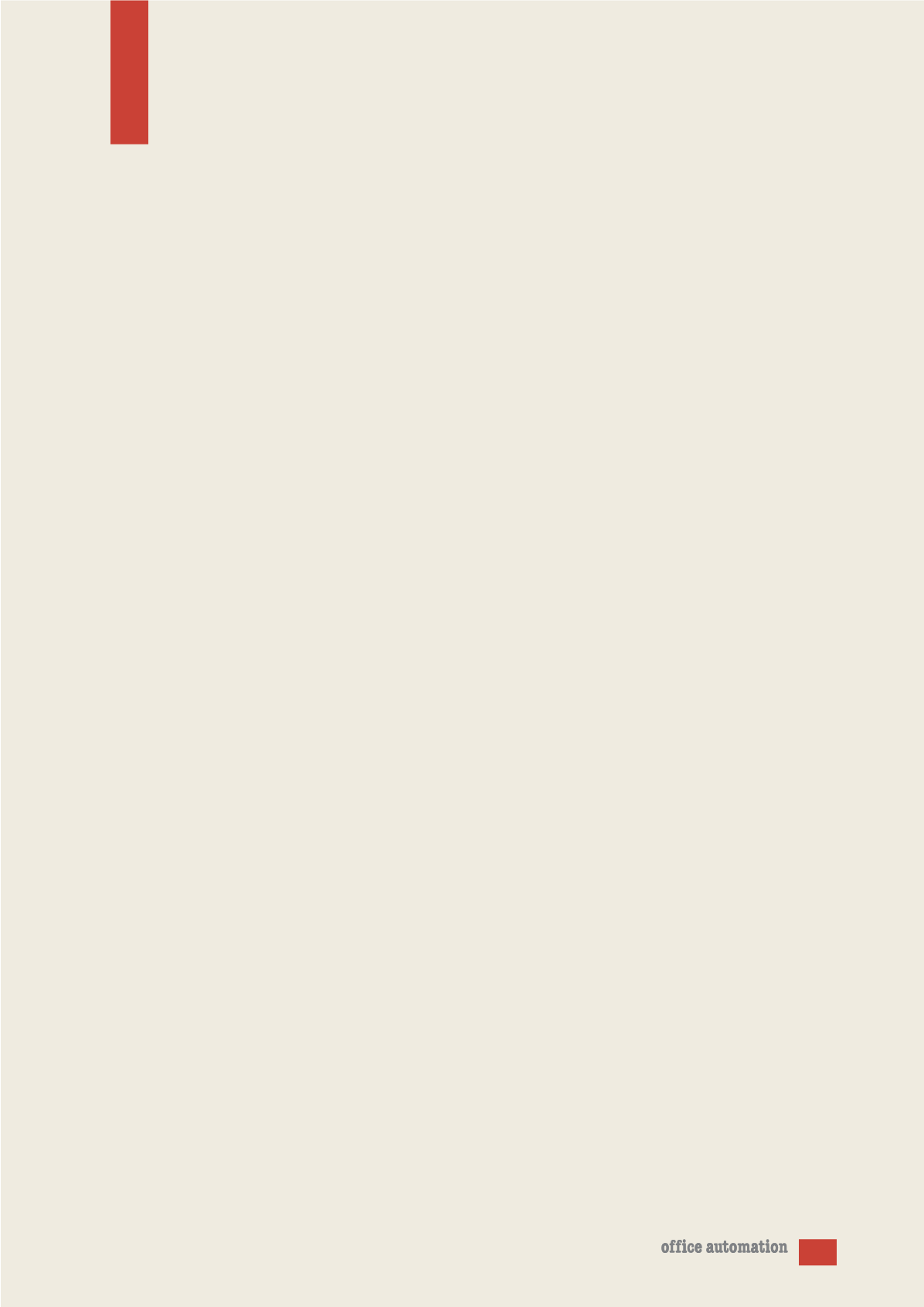
DITORIALE
1
Ha registrato un certo successo presso il pubblico italiano il libro ‘Lo Stato
Innovatore’ di Mariana Mazzucato, Editori Laterza, pubblicato all’inizio
dell’estate. In molti avranno avuto l’occasione di seguire la presentazione del
volume in diverse trasmissioni televisive, anche in prima serata, e questa è già
una ‘buona’ notizia visto che in Italia il tema dell’innovazione è poco di moda.
L’obiettivo centrato dall’autrice, docente di Economie dell’Innovazione presso
l’Università del Sussex in Gran Bretagna, è quello di ribaltare il senso comune
che vede, quando si parla di innovazione tecnologica, l’impresa privata
considerata da tutti come una forza innovativa, mentre lo Stato è bollato come
una forza inerziale, troppo grosso e pesante per fungere da motore dinamico.
Mariana Mazzucato dimostra infatti attraverso degli esempi storici – che oltre
all’industria ICT riguardano il settore farmaceutico e quello delle energie
rinnovabili – come la leva dell’investimento statale negli Stati Uniti sia risultata
fondamentale nella ricerca di base, in quella applicata e nelle politiche di
sostegno della domanda e dell’offerta, per realizzare prodotti e soluzioni oggi di
uso comune. E questo ben prima dell’investimento dei ‘mitici’ venture capitalist
che arrivano quando invece la maggior parte dei rischi legati all’investimento
nelle attività di ricerca sono stati già fatti, appunto dallo Stato.
Ciò che invece succede, sostiene l’autrice, è che le aziende che più hanno
beneficiato di queste attività di stimolo e ricerca una volta raggiunto il successo
– misurabile con ritorni di decine di miliardi di dollari nei loro conti aziendali –,
non solo non spendono una parola per riconoscere il ruolo giocato dal pubblico,
ma compiono pochi investimenti di tipo ‘sociale’, a beneficio dei loro lavoratori
e dei territori che ospitano i loro impianti produttivi, e inoltre agiscono in
modo da ridurre al minimo l’impatto delle tasse sui loro guadagni, sottraendo
così linfa vitale anche a quei fondi statali che hanno il compito di finanziare
nuova ricerca e nuove politiche di sostegno della domanda e dell’offerta. Per
continuare a produrre innovazione anche in futuro, l’autrice sostiene quindi che
oggi è più che mai necessario che si materializzano questi ritorni.
In generale il libro è portatore una tesi in gran parte condivisibile, ma che può
essere contestata in diversi punti, e se nascerà un dibattito pubblico su questi
temi è importante che questo si indirizzi in modo costruttivo nella ricerca
di nuovi strumenti di fiscalità adeguati a sostenere l’innovazione. Tenendo
conto però di due fattori. Il primo è che la globalizzazione delle conoscenze
dei risultati della ricerca scientifica promossa dallo Stato oggi difficilmente
rimangono confinati nei singoli Paesi che l’hanno finanziata. E il libro stesso
riconosce come gli errori compiuti negli USA in merito alle politiche di sostegno
delle energie rinnovabili hanno favorito aziende di altre nazioni.
E il secondo importante punto è il fatto che oltre alla ricerca, fattore abilitante
fondamentale, entrano in campo molti altri fattori per fare di un’innovazione un
successo di business.
Tra questi si possono citare la capacità tecnologica di realizzare integrazioni
delle diverse componenti in modo sofisticato, le strategie di marketing, il design
di prodotto, le politiche che individuano i mercati strategici in cui un’azienda
deve essere presente, le capacità commerciali e molto altro. Insomma
portare al successo un’innovazione non dipende solo dalla componente, pur
fondamentale, della ricerca. Si facciano bene i conti, quindi per non togliere
ossigeno all’altrettanta fondamentale componente: quella del business.
Ruggero Vota
Non basta la ricerca
per fare dell’innovazione un business
ottobre 2014